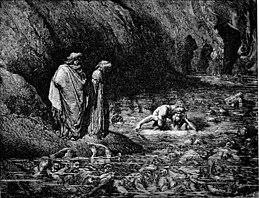
La trasmutazione cui sono andate incontro le sinistre di tutto l’Occidente nel corso degli ultimi trent’anni non è certo una novità per gli affezionati lettori della Chiosa. Nel piccolo delle nostre riflessioni, abbiamo più volte fatto riferimento a questo processo storico singolare che ha inciso così profondamente sulle dinamiche dell’attuale dialettica politica. E non possiamo neppure vantarci di esser stati gli unici o tanto meno i primi a rilevare questo fenomeno: il tradimento del Lavoro perpetrato dalle socialdemocrazie in favore delle lusinghe del Capitale sovranazionale sarà stato anche ben dissimulato dalla fine degli anni ‘80 fino al 2008, ma dalla crisi in poi è divenuto fin troppo evidente. Oggi come oggi gli unici a non essersene ancora accorti sono quelli che non se ne vogliono accorgere e che scelgono fideisticamente di fare orecchie da mercante di fronte a ogni evidenza. Purtroppo per costoro c’è poco da fare, è tristemente noto che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Se è vero quindi che la fenomenologia di questa transizione è stata ampiamente sviscerata da personalità di ben altro calibro rispetto al sottoscritto, poco o nulla si è detto sulle cause di questo processo. O per lo meno io non ho mai avuto il piacere di imbattermi in un’analisi che provasse a indagare le motivazioni dietro al voltafaccia che ha impegnato negli ultimi decenni tutte le intellighenzie sinistrorse. Cosa può aver spinto i quadri dei partiti dei lavoratori a tradire il proprio mandato storico e a spiegare le vele al vento atlantico del neoliberismo? Com’è stato possibile che quegli intellettuali con l’eschimo, che per tutti gli anni ’70 avevano sventolato bandiere rosse dalle barricate, abbiano con gran disinvoltura rinnegato i propri ideali abbracciando la narrazione libdem e le invitanti prospettive del laissez-faire?
Insomma, per farla breve, assodato che questa silenziosa abiura si è verificata su più livelli e in varie forme, resta una domanda da porsi: perché?
Come di consueto, prima di mettermi a scrivere ho proposto l’argomento di questo articolo al resto della redazione. La risposta che ho ricevuto è stata semplice e sintetica. Una battuta lapidaria che ha sigillato la discussione in tre sillabe: “denaro” [1].
E in effetti è difficile non esser d’accordo. Quello sterco del demonio che nella sua natura eterea e inafferrabile costituisce l’essenza stessa del nostro modello di sviluppo è capace di qualunque cosa. Ma, strano a dirsi, il solo denaro questa volta non può esser l’unico responsabile di questa giravolta. Non foss’altro perché molte voci influenti del fu movimento operaio percepivano solidissimi e lautissimi stipendi statali, al sicuro (loro) dai capricci del libero mercato. Quindi ci dev’essere qualcosa di più profondo, che il mero mercimonio delle idee non può giustificare.
Una spiegazione più ad ampio spettro è quella che attribuisce questo cambio di vedute al conseguimento di una posizione sociale stabile e agiata da parte delle guide dei partiti dei lavoratori. Secondo questa visione, a seguito dell’adesione alla classe dominante, i singoli dirigenti avrebbero prima modulato e poi stravolto gli obiettivi della passata lotta politica e sindacale in nome dei propri interessi privati. Il cambio di rotta da forza di rottura a forza di conservazione quindi sarebbe stato volto a tutelare i privilegi ottenuti, finendo per dar credito storico al dileggiante motto “Caro compagno, tu lavori e io magno”.
Ora, lungi da me l’idea di voler smentire quest’interpretazione figlia di una scaltrezza contadina che oggi come non mai avremmo bisogno di recuperare: sicuramente per quanto riguarda i singoli capoccia è stato vero che il raggiungimento di condizioni migliori abbia tolto mordente alle rivendicazioni di piazza. Ma bisogna tenere a mente che il fenomeno che stiamo provando a indagare ha coinvolto le sinistre a trecentosessanta gradi, non ha lambito solo coloro che effettivamente avevano tratto vantaggio dalla leadership politica ottenuta e che avevano trovato posto nei ranghi dirigenziali di sindacati e partiti. C’era tutto un mondo di opinionisti e intellettuali la cui posizione sociale non era dipesa affatto dal credo politico e che avevano sposato sinceramente, almeno in apparenza, le cause del Lavoro negli anni ’60 e ’70.
Dunque se a livello microscopico la saggezza popolare ha saputo identificare uno degli elementi che ha contribuito alla perduellione delle sinistre, a livello macroscopico siamo ancora lontani dal poterci dire soddisfatti.
Un elemento storico che sicuramente ha ricoperto un ruolo di centrale importanza all’interno della nostra vicenda è lo sfaldamento del blocco sovietico. Il crollo del principale modello alternativo a quello capitalista sancito dalla vittoria americana nella guerra fredda ebbe enormi conseguenze su tutto il pianeta: perlopiù economiche in Occidente, soprattutto militari nel secondo e terzo mondo. A voler essere pignoli, già nella seconda metà degli anni ’80 era stato dato il la a quel processo noto al secolo come globalizzazione, ma fu solo dopo la caduta del muro di Berlino che questa assunse finalmente le fattezze definitive di monarchia mondiale del dollaro con capitale a Washington.
Sebbene le tempistiche suggeriscano impietosamente una forte correlazione tra la fellonia in esame e l'abbattimento della cortina di ferro, non è immediato stabilire un nesso causale tra questi eventi. È indiscutibile infatti che la fine dell’URSS abbia implicato un indebolimento, specie a livello finanziario, dei partiti comunisti europei, ma questo non spiega in alcun modo perché i loro leader avrebbero dovuto correggere il tiro del proprio mandato politico. Per di più, proprio negli anni in cui si cominciava ad assistere all’erosione dei diritti sociali a cui condannava la formazione di un mercato globale per merci e lavoro.
Uno spunto interessante per sciogliere questo nodo lo fornisce la storia, e in particolare il Rinascimento. Nel ‘500 italiano infatti sotto il profilo culturale si assiste alla consacrazione del ruolo cortigiano degli intellettuali. Certo, non è una novità: è almeno dai tempi di Augusto (per non dire da sempre) che gli studiosi cercano protezione sotto l’ala dei potenti mettendo a disposizione il proprio genio. Però nel Rinascimento il mecenatismo signorile formalizza ed eleva a prassi un fenomeno che era rimasto quiescente per oltre mille anni. Da questo momento in poi gli uomini di cultura si direzioneranno con sempre maggior uniformità e disinvoltura nella direzione in cui soffia il vento. E come non capirli: in fin dei conti la capacità di adattamento è diretta conseguenza di quell’intelligenza di cui sono dotati per definizione.
Attenzione: non si cerchi di ravvedere in questa riflessione una retorica moralista contro la categoria degli intellettuali. Nessuno qui pensa, tanto per fare un esempio, che i docenti universitari che nel 1931 giurarono fedeltà al regime fascista siano degli opportunisti o dei venduti [2]. In quelle determinate circostanze storiche va tributato sicuramente grande onore alla coerenza di chi decise di perdere la cattedra pur di non cedere a un’ideologia che avversava, ma non ha alcun senso condannare chi decise di firmare magari anche turandosi il naso. È molto semplice fare i duri e puri con il culo degli altri, evitiamo di cadere in tentazione. Qui c’è solo il tentativo di registrare un dato fenomenologico abbastanza inoppugnabile, ossia che statisticamente gli intellettuali tendono ad allinearsi al potere più agilmente degli altri.
Così con il crollo dell’Unione Sovietica e l’incoronazione dell’egemonia mondiale a stelle e strisce, il vento ha iniziato a soffiare in un verso ben preciso. Riallinearsi diventò nei primi anni ’90 una necessità cogente, meglio percepita da chi meglio fiutava la direzione in cui si stava avviando la Storia. Con un gioco di parole potremmo dire che fu proprio l’intelligenza a spingere l’intellighenzia di sinistra ad assecondare il percorso storico che si stava tracciando in quegli anni e che avrebbe marchiato indelebilmente la società dei decenni avvenire. E questo naturalmente vale sia per i politici di professione che per gli opinion leader extra-parlamentari. I primi, intuito l’andazzo che spostava dalla politica al mercato le vere leve del potere, capirono subito che conveniva tirare i remi in barca: era giunta l’ora di ammainare le vele con la falce e martello per issare quelle della socialdemocrazia (di nome ma non di fatto). I secondi, ben consapevoli delle blandizie che il Potere riserva alle proprie vestali, non sfuggirono all’indole cortigiana cui il loro genio li condannava e gradualmente abbandonarono ogni rivendicazione sociale imbracciando una retorica del progresso che parlava di ultimi strizzando l’occhio ai primi.
Con il rischio di ripetermi, voglio ribadire che in questa sede non si vuol proporre un’invettiva contro gli intellettuali di sinistra, dipinti come abili trasformisti che si sarebbero venduti al miglior offerente. Anzi, al contrario, si vuol metter in luce senza rancorosi sentimentalismi come sia stato quasi naturale il riposizionamento di chi aveva saputo leggere in anticipo il flusso degli eventi e l’ha assecondato. E occhio perché, prestandovi attenzione, ci si accorge che questo processo di riallineamento non è qualcosa che appartiene al passato. Lo osserviamo anche oggi, magari volgendo lo sguardo su quegli intellettuali un pochino più lungimiranti, che proprio in virtù dell’intelligenza sono stati capaci di non fossilizzarsi su posizioni monolitiche e di mantenere una notevole sensibilità sociale. Per fare un esempio concreto, penso a Federico Rampini, giornalista di grande spessore di cui personalmente non condivido in blocco il pensiero ma cui non si può certo non riconoscere il merito di essere un fine analista dell’attualità politica occidentale. Ebbene, proprio lui che nel '96 era stato cantore del modello tedesco e nel 2009 della corsa di Obama alla presidenza USA, da qualche anno (da prima della sorprendente vittoria di Trump del 2016) si è riscoperto impietoso critico dei dem americani e, va da sé, di quelli nostrani che li seguono a ruota.
Si capisce ora il mio punto? Rampini, della cui indipendenza ideologica offrono garanzia le improbabili bretelle, non è un sorcio che abbandona la nave dopo aver fiutato delle perdite nello scafo, non ne ha alcun bisogno materiale. È un intellettuale di razza e in quanto tale intuisce e asseconda il cambio di rotta che la Storia sta prendendo.
Poi certo, senza ipocrisie bisogna ammettere che ci sono anche molti che hanno cambiato casacca per mera convenienza, senza aver avuto alcuna epifania e con assoluta contezza del tradimento in corso. Tanto per avere un’idea piuttosto precisa dei soggetti cui alludo, si scorra lo storico dei membri della redazione di cui è corrispondente dagli Stati Uniti lo stesso Rampini. A partire dal fondatore. Se è vero infatti che gli intellettuali più acuti si sono dimostrati capaci di rinnovarsi ancora una volta rigettando i dogmi a lungo onorati, questa rumorosa (e tragicamente vasta) porzione di opinionisti obnubilati dal profumo del banchetto liberista ha perso quel fiuto che trent'anni fa aveva saputo portarla in auge. Costoro hanno perso ogni contatto con la società, ogni contatto con il popolo. Lo stesso termine, "popolo", con cui un tempo si riempivano la bocca, ora lo pronunciano con schiumante disprezzo. Si sono ritrovati nella scomoda posizione di esser più realisti del re e, pur non volendosi rassegnare, sono ben consci di esser giunti alla fase discendente della propria parabola.
E almeno su questo, per fortuna, non si sbagliano.
Note
[1] Naturalmente l’autore di quest’uscita tombale è stato l’anziano Adalberto Meucci Masoni.
[2] A voler essere precisi, furono meno di una ventina su oltre 1200 i docenti universitari che persero la propria cattedra per essersi rifiutati di prestare giuramento di fedeltà al fascismo.









